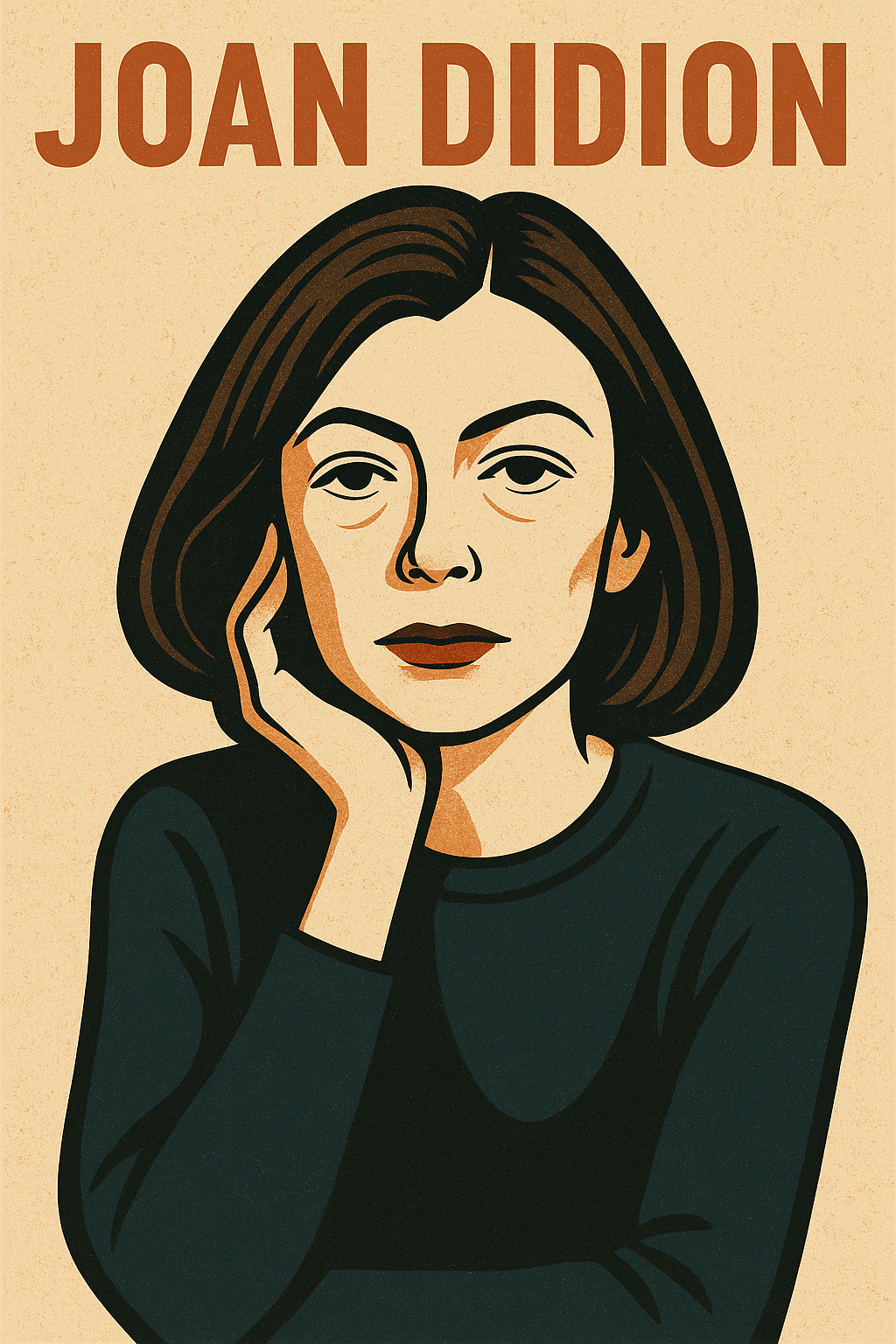Didion, la coscienza di un passato importante della cultura americana. Ma cosa accade quando la voce più precisa del Novecento si rivolge a sé stessa?
Ci sono scrittrici che si leggono e scrittrici che si vivono: Joan Didion, per me, appartiene alla seconda categoria. La sua voce mi ha accompagnata nei momenti di smarrimento e nelle ore di scoperta, insegnandomi che la realtà spesso racchiude una ferocia che il mondo delle idee fatica a contemplare. Rileggerla oggi, tra le nuove pubblicazioni italiane e i suoi grandi capolavori, è come entrare in dialogo con una presenza che parla a chi scrive e, soprattutto, a chi si ostina a pensare.
Ricordo il mio primo incontro con Didion: una copia de L’anno del pensiero magico ritrovata su uno scaffale di casa. Uno di quei libri che compri con l’idea che prima o poi leggerai, perché Didion non può mancare nel corredo di una donna che scrive. Vivevo giorni inquieti e tra quelle pagine ho incontrato una scrittura che non consolava ma chiariva: Didion raccontava la perdita e il dolore trasformandoli in pensiero, mantenendo una grana quasi soprannaturale, come se desse per scontato che ogni ferita potesse essere indistintamente carne e linguaggio. Da allora, ogni suo libro per me è stato un treno preso per necessità.
Se oggi Didion viene celebrata come maestra di lucidità, è perché la sua poetica si è costruita nel tempo su una posizione periferica rispetto alle idee più ascoltate. Il mio libro preferito, e credo anche paradigmatico per capire il suo schema di pensiero al di fuori dei romanzi politici, è Prendila così (Play It as It Lays), pubblicato nel 1970 e riportato in Italia da Il Saggiatore. Il romanzo mette in scena Maria, attrice di Hollywood, attraversata da una disperazione che diventa quasi lingua madre. Didion non cerca di spiegare il dolore della protagonista: lo mostra, lo fa pulsare nel ritmo frammentato e nelle pause, che sembrano respiri trattenuti. In Maria, come in tante sue protagoniste, la sofferenza femminile è analizzata senza autocommiserazione, senza paternalismo, senza ricorrere a facili etichette. Così Didion riesce a descrivere il legame tra genere e autodeterminazione e la difficoltà di definirsi in una realtà spesso caotica e incoerente.
Negli ultimi anni Il Saggiatore ha svolto un lavoro prezioso portando in Italia le opere più recenti e intime dell’autrice, offrendo ai lettori la possibilità di vedere Didion sotto una luce nuova. Dopo la sua morte, il 23 dicembre 2021, è stata trovata una cartellina con numerosi documenti, tra cui un manoscritto di circa centocinquanta pagine: un vero diario delle sedute con lo psichiatra MacKinnon, raccolte dal 1999 al 2012. Questo scritto nasce come una sorta di dialogo epistolare rivolto al marito John Gregory Dunne, iniziato dopo alcune sedute nel dicembre 1999 e proseguito soprattutto l’anno successivo. Il manoscritto, assieme all’archivio Didion-Dunne, è stato affidato alla New York Public Library dagli eredi, senza limitazioni di accesso. Proprio questa libera consultabilità ha spinto i fiduciari di Didion a trasporre il documento in volume, pubblicato negli Stati Uniti da Knopf e in Italia da Il Saggiatore.
La decisione di rendere pubbliche pagine così intime, ricche di dettagli sulla vita familiare e personale dell’autrice, ha suscitato comprensibili controversie. Amici e conoscenti hanno parlato di violazione della privacy, certi che Didion non avrebbe mai dato il suo consenso. Altri, invece, ritengono che, data la sua notorietà, l’autrice avrebbe potuto prevedere questa eventualità.
Il rapporto tra Didion e la figlia adottiva Quintana, scomparsa prematuramente, è il fulcro emotivo di Diario per John. Didion, su consiglio della stessa Quintana, inizia a confrontarsi con MacKinnon per affrontare la propria fragilità e la dolorosa consapevolezza della dipendenza emotiva tra madre e figlia. Da queste pagine emerge un’ossessione: la paura costante di perdere la persona amata, la sensazione di non meritare la felicità, la scelta di esprimere l’amore attraverso una protezione che rischia di essere soffocante. Seduta dopo seduta, l’autrice scava nelle origini di questo sentimento, radicato nell’infanzia e nel rapporto travagliato con il padre. MacKinnon cerca di guidarla verso un nuovo approccio: aiutare Quintana non significa proteggerla a tutti i costi, ma imparare a darle fiducia, lasciandole la libertà di cadere e rialzarsi, di diventare adulta. Joan fatica ad accettare che il suo sostegno non sia sempre risolutivo; emergono frustrazione e impotenza, così come il ricorso al lavoro per tenere a bada l’ansia e la rabbia. Didion riflette anche sulla relazione simbiotica con il marito John e sull’insoddisfazione per la routine delle sceneggiature, sentendo la necessità di impegnarsi in un progetto autentico. Nel tempo, impara a riconoscere lo schema di paure e sensi di colpa che si tramandano nella sua famiglia.
L’ultima seduta registrata, datata 9 gennaio 2003, precede di poco il lutto devastante per la morte di John e poi, a breve distanza, anche quella di Quintana. Didion affronterà queste perdite nei suoi libri più noti, L’anno del pensiero magico e Blue Nights, dove la scrittura diventa strumento di sopravvivenza: Didion si obbliga a prendere distanza dal proprio dolore, a scavare con lucidità tra le rovine della sua vita.
A questo punto, è impossibile non ricordare le stesse parole di Didion su Ernest Hemingway, quando si interrogava sulla legittimità delle pubblicazioni postume. In Ultime parole, la scrittrice sottolineava come queste uscite rischino di trasformare l’arte dello scrivere in produzione seriale, negando la natura profonda del mestiere: la creazione consapevole, il controllo sulla propria voce e sulla propria eredità. La grammatica delle frasi, ammoniva Didion, è un modo di essere nel mondo, di attraversarlo mantenendo una certa distanza emotiva che permette di raccontare senza esserne travolti.
Oggi, davanti a Diario per John, ci troviamo di fronte a un dilemma etico, senza però ignorare l’importanza che lo studio di questo documento potrebbe avere, non solo per la figura di Didion scrittrice, ma anche per una maggiore emersione della condizione femminile dal punto di vista storico e sociale. È un dilemma che attraversa molte autrici contemporanee: pensiamo a Rachel Cusk, che nei suoi memoir e romanzi mette in scena il conflitto tra conscio e inconscio, tra la voce individuale e quella collettiva, tra libertà e dipendenza. Rachel Cusk, scrittrice britannica di origini canadesi, si distingue per uno stile spietatamente analitico e una narrazione che destruttura le certezze dell’identità femminile. Cusk indaga con precisione quasi chirurgica la maternità, la dissoluzione della coppia e la solitudine, rifiutando ogni idealizzazione. Attraverso una scrittura fatta di sottrazioni e silenzi, l’autrice svela il conflitto tra desiderio di libertà e peso delle aspettative sociali, tra necessità di esprimersi e tentazione di dissolversi nella collettività. Come Didion, Cusk non cerca risposte definitive, ma spinge lettrici e lettori a interrogarsi sulla porosità dell’io, sulla fragilità della narrazione personale e sulla possibilità che la verità si costruisca solo nel dialogo con l’altro.
In Ultime interviste (sempre Il Saggiatore), Didion regala otto conversazioni con giornalisti e scrittori, da Sheila Heti a Dave Eggers, in cui ripercorre la sua vita, dalla California a New York, dagli anni a Vogue ai tremendi lutti. Questa delle ultime interviste è ancora un’altra Didion: ironica, severa, sempre con la sigaretta accesa e la battuta pronta, che mostra la sua ossessione per la verità e l’avversione per le narrazioni che anestetizzano il dolore. In queste pagine, però, si percepisce la continuità tra la Didion storica e quella più recente: la capacità di inventare sulla pagina senza sapere dove si arriverà, la consapevolezza che la scrittura è vera solo se chi scrive accetta di non avere il controllo sul finale.
Poi ci sono testi che sembrano attendere il loro momento, come il discorso di laurea che Didion tenne all’Università della California, Riverside, nel 1975: oltre tremila parole rimaste per quasi mezzo secolo confinate in una vecchia pubblicazione per ex studenti, mai digitalizzata, quasi dimenticata. Dopo la morte della scrittrice, quel testo è stato recuperato e restituito al mondo. Didion apre ricordando la sua cerimonia di diploma di terza media, quando aveva tredici anni: un abito verde pallido cucito dalla madre, una collana di cristallo fredda sulla pelle, una bandiera americana alle spalle. Quella ragazzina, che parlava con entusiasmo dell’“eredità californiana”, credeva che la storia della propria famiglia, pionieri che avevano attraversato le montagne un secolo prima, fosse la storia di tutti i presenti in sala. Solo da adulta capirà quanto fosse cieca quella convinzione: molti compagni non discendevano da cercatori d’oro, ma da famiglie arrivate a Sacramento durante le migrazioni della Dust Bowl o per lavorare nei cantieri navali durante la guerra. È il primo trauma cognitivo di cui Didion parla: la scoperta che gli altri non vivono nel nostro stesso film. Che ciò che crediamo universale è spesso soltanto personale. Che le nostre idee, composte da anni di studio o regalate da una qualsiasi eredità culturale, possono accecarci. Per Didion quella confusione infantile non è un episodio isolato, ma il sintomo di una fatica che avrebbe accompagnato tutta la sua vita: l’impegno costante a liberarsi dalle interpretazioni comode, dalle distorsioni, dagli automatismi mentali. Vedere davvero, sembra dirci, è un lavoro doloroso e continuo. Non basta osservare: bisogna rinunciare alle semplificazioni che ci rassicurano. Bisogna accettare che la realtà spesso non coincide con i nostri desideri, che gli altri non sono mai come li immaginavamo. Restare svegli, per Didion, è una disciplina e un obbligo morale.
Nel discorso, la scrittrice torna più volte sul rischio di vivere dentro un’idea invece che nel mondo. Racconta di aver letto, su un giornale, la poesia di un’adolescente che elogiava innocenza, natura e sneakers come simboli di purezza quasi rituale. Nulla di sbagliato, in sé. Eppure Didion, leggendo quei versi, si sente inquieta: percepisce l’ingenuità di chi tenta di costruirsi un rifugio ideale per non vedere la parte dolorosa del reale, quella raccontata dalle pagine successive dello stesso giornale, piene di violenza e oscurità politica. Insomma, per Didion, “piantare un albero” non può diventare uno stile di vita. Le buone intenzioni non bastano se diventano alibi per chiudersi dentro un’innocenza immaginaria.
Gran parte del discorso è dedicata agli anni Sessanta, che Didion osserva come un territorio in cui la distanza tra simboli e realtà è divenuta abissale. È stata un’epoca in cui ogni gesto, ogni capo d’abbigliamento, ogni alimento si è caricato di significati morali, e allo stesso tempo ha perso qualunque ancoraggio concreto. La scrittrice ricorda come persino il linguaggio si sia deformato: eufemismi di guerra, slogan politici, parole che suonavano importanti ma non dicevano nulla. Tutto era diventato segno, quasi più nulla somigliava a un’esperienza autentica. Chi è cresciuto in quel clima, suggerisce Didion ai neolaureati del ‘75, ha sviluppato una naturale diffidenza verso ideologie e formule, ed è forse al riparo da alcuni inganni. Ma resta il pericolo di non credere più a niente, di rimanere soli in un mondo in cui si pianta un albero e ci si convince che basti così. Il cuore del messaggio è un’esortazione che oggi suona ancora più urgente: non chiudersi, non semplificare, non ritrarsi in un eden interiore. Didion non promette progresso né redenzione, ma chiede un atto di volontà: abitare il mondo nella sua complessità, nella sua bruttezza e nella sua bellezza, assumendosi il rischio di vedere ciò che non vorremmo vedere.
Rileggere Didion oggi significa mettere in dialogo due voci che in realtà sono sempre state una: quella della scrittrice che inventa storie politiche per sopravvivere al mondo e quella della donna che scrive per capire se stessa e cosa generano intorno a lei, la visione degli altri, della realtà, della storia. La differenza sta nel grado di distanza, nella scelta di cosa mostrare e cosa tenere nascosto. Nei suoi romanzi e saggi lavora di sottrazione, osserva da lontano, cesella la forma per dare senso al caos. Nei libri più recenti, invece, si lascia andare a una verità quasi imbarazzante, una vulnerabilità che fa tremare i polsi.
Quali sono, allora, le lezioni che una scrittrice contemporanea può trarre da Joan Didion? La prima è che la verità, in letteratura, non è mai trasparenza naturale, ma costruzione, esattezza, linguaggio. La realtà non va data per scontata: bisogna interrogarla, smontarla, guardarla sempre dal margine, dove le cose si vedono meglio.
La seconda lezione riguarda la fragilità: in un’epoca in cui essa viene percepita come una minaccia e la verità appare sempre più negoziabile, le opere di Didion, da Prendila così a Diario per John, passando per Ultime interviste, ci insegnano che la grande letteratura sa e deve dialogare con lo sconcerto e lo smarrimento.
In questa puntata di Diaria Podcast e del video della Diaria: Joan Didion. Oggi, le sue vere “ultime parole” ci raggiungono grazie alle pubblicazioni postume de Il Saggiatore, in particolare con due titoli cruciali: Ultime interviste, dove Didion risponde con estrema franchezza sui temi più dolorosi, dalla morte del marito John Gregory Dunne a quella della figlia Quintana; e soprattutto, con Diario per John.
In questo episodio di Diaria Podcast e video, scopriremo l’eredità lasciata da Joan Didion: la necessità di lottare contro le proprie idee distorte della realtà, e l’onestà brutale con cui ha saputo scrutare sé stessa, fino all’ultima parola.